Ascoltare e riadattarsi

In questo lungo periodo di emergenza sanitaria e di lock down ho pensato spesso a cosa avrei potuto scrivere, a quali riflessioni proporre, a quali “consigli” sarebbe stato utile dare. Siamo stati bombardati di notizie, informazioni, indicazioni e in molti hanno “detto la loro”, in modo in realtà non sempre appropriato. Personalmente ho sentito preferibile stare nella situazione e dedicare spazio all’ascolto, di me stessa e dei pazienti. Sono stati mesi in cui ho accolto emozioni e riflessioni che talvolta potevano apparire contrastanti, ma che di fatto coesistevano in una situazione che, tuttora, è per molti versi confusa. Non esistono modi “giusti” o del tutto prevedibili di affrontare quanto è accaduto e sta accadendo e come professionisti è nostro compito esserci, ascoltare, contenere tutto ciò che emerge. La crisi ha colpito a molti livelli ed è andata a toccare corde differenti in ciascuno, in base al funzionamento di personalità, alle esperienze concrete vissute, ai contesti e alle condizioni di vita.
Paura, rabbia, angoscia, delusione, noia, impotenza, confusione. Ma anche benessere, scoperta, risorse positive. Ho ascoltato il desiderio, talvolta bisogno urgente, di “tornare come prima”, esattamente così e subito, altrimenti niente. La paura che “come prima” non si tornerà più. Al contempo la paura di contagiare, contagiarsi, ripiombare nell’emergenza. La malattia come qualcosa di lontano o al contrario vissuto sulla propria pelle. Il lutto che in assenza della consueta ritualità ha dovuto trovare nuove strade di elaborazione. La rabbia per i limiti imposti, ma anche dovuta all’angoscia perché ci si è trovati esposti alla precarietà, alla perdita improvvisa, spesso senza aiuti concreti. La solitudine. La scoperta che gli altri sono importanti, ma anche che si è capaci di stare da soli. La possibilità di fermarsi e finalmente riposare, ma anche l’impossibilità di farlo perché schiacciati da un numero ancora maggiore di incombenze quotidiane. Il vuoto che in realtà è pieno di cose, la scoperta che si può stare faccia a faccia con sé stessi o che si ha troppa paura per farlo. La difficoltà a confrontarsi con l’attesa, ma anche la capacità di affrontarla perché è qualcosa che si conosce bene. La sensazione che ci sia un’energia che vorrebbe venire fuori, ma è difficile darle una forma perché ci si sente annebbiati, stanchi. La consapevolezza che senza “rumore di fondo” sono rimaste le cose essenziali, quelle importanti, ma anche che a volte sono proprio quelle a non andare come vorremmo ed è venuto il momento di occuparsene invece di continuare a scappare.
Nella crisi c’è anche l’opportunità, ma prima è normale che ci siano confusione e paura. C’è lo sconforto di chi non sa in che direzione andare. C’è la lotta di chi pesta i piedi perché non è questo quello che voleva. Arriva però anche il tempo dell’adattamento, che non significa non-vivere o vivere un surrogato di ciò che era prima, ma accettare che qualcosa è accaduto, che non esistono magiche macchine del tempo, ma possiamo provare a costruire nuovi equilibri che tengano insieme realtà e bisogni. Siamo capaci di farlo, tutta la nostra vita è stata un continuo ri-adattarsi ai cambiamenti fuori e dentro di noi. Possiamo farlo ancora, dobbiamo provarci ancora, perché nonostante tutto siamo qui, respiriamo, pensiamo, proviamo emozioni, insomma siamo vivi.
Esprimersi attraverso l’arte
L’arte è una forma di linguaggio non verbale che da sempre permette di esprimere emozioni e punti di vista sul mondo e che può suscitare in noi riflessioni e sensazioni anche intense.
Nei musei troviamo le più alte espressioni artistiche, ma anche nel nostro piccolo l’arte può diventare un mezzo per rilassarsi ed esprimersi: basti pensare alle situazioni in cui ascoltare della musica ci fa sentire meglio o ai momenti in cui ci viene spontaneo scarabocchiare un pezzo di carta per concentrarci o per scaricare la tensione. Tutti abbiamo una parte creativa e alcune persone mantengono un contatto con essa per lavoro o per hobby, ma nella maggior parte dei casi non abbiamo tempo oppure siamo fermamente convinti di non essere capaci di creare qualcosa.
I bambini sono di solito più abituati ad esprimersi usando colori, paste modellabili, costruzioni, ma anche inventando favole e canzoni. Crescendo di solito viene loro chiesto di dedicare maggiore tempo ad altre attività o di apprendere una qualche tecnica artistica. Ad esempio a scuola si insegna ai bambini a disegnare “bene”, spesso ad essere lodati sono i lavori più ordinati, allegri e realistici: i bambini possono convincersi precocemente di non essere capaci e talvolta davanti a un foglio bianco lamentano di non sapere cosa disegnare, faticando a lasciarsi andare spontaneamente. Da adulti poi usare materiale artistico può apparirci qualcosa di infantile, di inutile o di impossibile senza il possesso di adeguate conoscenze e abilità.
In realtà l’arte è prima di tutto uno strumento di espressione di sé e quindi possiamo provare ad abbandonarci al piacere di creare per creare: non dobbiamo dare vita a un prodotto esteticamente gradevole o tecnicamente perfetto, ma semplicemente lasciarci andare. L’arte ci aiuta infatti a connettere la nostra interiorità ed il mondo esterno. Ascoltarsi e riversare liberamente su un foglio forme, colori, immagini e parole ci aiuta di per sé a scaricare la tensione e ad attivare i nostri sensi. Possiamo poi osservare la nostra opera dall’esterno, in modo più distaccato, senza “psicanalizzare”, ma più semplicemente cogliendo le nostre sensazioni durante la creazione e individuando gli aspetti del prodotto che ci incuriosiscono o che ci ricordano qualcosa di noi e della nostra vita.
Disegnare, pitturare, colorare, comporre collage, usare la creta, scrivere e fare fotografie sono alcune azioni che possono aiutarci soprattutto nei periodi di confusione e stress o quanto accadono eventi importanti che non riusciamo magari a condividere ed esprimere a parole. L’arte infatti ci permette di “tirare fuori” ciò che abbiamo dentro in modo più immediato, di osservare dall’esterno e poi di riappropriarci di ciò che è nostro in una forma diversa.
Esercizi semplici ma molto utili in tal senso sono la costruzione di un diario visivo in cui tracciare quando ne sentiamo il bisogno opere grafiche del tutto spontanee oppure dedicare pochi minuti al giorno alla scrittura delle nostre sensazioni percettive ed emotive in quel momento. Riguardare anche a distanza di tempo ciò che si è prodotto è utile per cogliere i propri stati d’animo, per scoprire nuovi aspetti di sé e per rendersi conto che nonostante le difficoltà siamo sempre in cambiamento e andiamo avanti.
Oltre la paura per conoscere i figli adolescenti
Capita spesso che i genitori portino in terapia il proprio figlio adolescente o pre-adolescente bollandolo come “il problema” o definendo i suoi comportamenti come problematici. Talvolta sono presenti sintomi veri e propri che parlano di una sofferenza già molto profonda, in altri casi i genitori riportano che i figli non ascoltano, non si impegnano, non dialogano con loro, passano tutto il tempo con gli amici o chiusi in casa. Elemento comune è di solito la rigida focalizzazione sugli aspetti negativi, ma se il figlio si sente solo “un problema” e non una persona degna di parola, allora difficilmente si potrà lavorare insieme e trovare una soluzione.
Siamo forse poco abituati a pensare all’adolescenza al di là degli aspetti di crisi, come fase che ha in sé anche elementi positivi o quantomeno di potenziali risorse. L’adolescente non è bambino, non è adulto, ma è persona con i suoi pensieri, vissuti e caratteristiche, seppur in trasformazione. Spesso la comprensibile angoscia e rabbia degli adulti impedisce di porsi una domanda importante: quanto conosco mio figlio come persona? sono in grado di descrivere cosa gli piace, cosa pensa, cosa desidera o come funziona nelle diverse situazioni? Spesso non si riesce ad andare oltre le etichette rigide e stigmatizzanti, ma bisogna sforzarsi di osservare sospendendo il giudizio e ritrovare una curiosità per quel figlio che pure può apparire lontano.
Talvolta la curiosità è bloccata dalla paura. Molti genitori vorrebbero che il figlio tornasse “come prima, quello che è davvero”, intendendo il bambino dolce e simpatico che è stato fino a un certo punto. In realtà il figlio cresce ma è sempre lui, non accettare che possa tirare fuori parti di sé che magari non ci piacciono o ci mettono in crisi significa lanciare un messaggio pericoloso: non vai bene, sei sbagliato. Chiusura, vergogna, senso di colpa, fino all’esplosione di sintomi anche importanti rischiano di essere la risposta.
Spesso mi è capitato di incontrare ragazzi con una grande confusione e sofferenza interiore, impossibilitati ad esprimersi perché timorosi di ferire gli adulti, di essere disapprovati, di non essere aiutati. Una volta un genitore ha raccontato “mio figlio mi guarda con degli occhi che vorrebbero dire tanto, ma non dice, come se aspettasse che io lo legga dentro, ma io non sono capace”. In effetti è proprio così, molti ragazzi sperano che gli adulti siano in grado di immaginare cosa provano, cosa vivono, di cosa hanno bisogno, che siano loro ad aiutarli a fare chiarezza, a dare un nome alle cose e a rassicurarli del fatto che sono normali, contenendoli, trovando insieme una soluzione. La delusione è grande quando i genitori non riescono mai a fare questo: se non sono comprensibile neanche ai miei genitori, come potranno comprendermi gli altri? vuol dire allora che sono sbagliato?
Spesso gli adulti riferiscono di sentirsi estromessi dalla vita dei figli, ma al contempo può emergere la paura di conoscere o una scarsa curiosità. Quanto siamo capaci di osservare, dialogare, ascoltare senza proporre subito i nostri giudizi e punti di vista e senza dare per scontato di sapere tutto o di essere stati figli “migliori”? Se oggi i figli sono l’apice della realizzazione personale, se ogni difficoltà diventa prova della propria incapacità genitoriale, allora il rischio è essere guidati dalla paura, lasciare i figli da soli allo sbaraglio o diventare eccessivamente rigidi per poi scaricare su di loro la colpa se qualcosa va storto.
Le difficoltà dei genitori sono assolutamente comprensibili, ma è importante che loro per primi siano onesti rispetto ai propri sentimenti e difficoltà, che d’altra parte non riguardano solo i comportamenti dei figli, ma anche ciò che capita in altre aree della vita. Ciascuno ha i propri pesi quotidiani da gestire e adolescenza significa anche accettare che i figli crescano, che i nonni invecchino, dovere reinvestire su di sé e sulla coppia. Non è semplice stare dietro agli equilibri che cambiano, ma invece di nascondersi è importante dialogare e costruire una rete di supporto. Se i figli diventano il capro espiatorio o portatori di pesi che non competono loro il rischio è che tentino una sfida impossibile: non crescere, chiudendosi o costruendo un’identità negativa, consentendo ai genitori di deviare su di loro tutta la tensione.
Dobbiamo anche chiederci che idea della crescita, dell’adolescenza e dell’età adulta trasmettiamo ai ragazzi di oggi, anche sulla base delle nostre esperienze passate. Se l’adolescenza è per forza “tutto rose e fiori” come potrò confidarmi con gli adulti quando mi sento confuso e per nulla felice? Se ci si aspetta che io diventi adulto e autonomo tutto d’un colpo come potrò chiedere aiuto se non mi sento capace? come posso crescere con fiducia se diventare grandi vuol dire recidere i legami familiari ed entrare in un mondo adulto fatto solo di fatiche e delusioni? I nostri racconti, i nostri atteggiamenti influenzano le convinzioni dei ragazzi, che oggi spesso partono già spaventati dal futuro.
Proviamo a non pensare all’adolescenza come alla fase in cui si spicca il volo, ma al momento in cui si costruiscono gli strumenti per farlo più avanti. C’è bisogno di allontanarsi un po’ per sperimentare e poi tornare al porto sicuro per elaborare le esperienze fatte, c’è bisogno di adulti che ascoltino ed insegnino ad ascoltarsi, conoscersi, trovare dei confini adeguati. Provocazioni, litigi, ambivalenze e malumori non sono un rifiuto, ma un tentativo di testare la tenuta dei legami e così il lassismo o l’eccessiva rigidità diventano segnali di abbandono. Non evitiamo dunque il conflitto, ma facciamo sì che diventi uno spazio per scontrarsi e incontrarsi, riconoscere limiti e risorse, sperimentarsi con la consapevolezza che i legami affettivi restano saldi.
Io e te…due metà della stessa mela?
Spesso quando si pensa alle relazioni di coppia la mente vola all’immagine delle due metà della mela che insieme formano un bellissimo frutto: siamo alla ricerca dell’anima gemella, quella “dolce metà” che potrà farci sentire finalmente completi, come due pezzi di un puzzle che si incastrano perfettamente.
delle due metà della mela che insieme formano un bellissimo frutto: siamo alla ricerca dell’anima gemella, quella “dolce metà” che potrà farci sentire finalmente completi, come due pezzi di un puzzle che si incastrano perfettamente.
Ma cosa ci influenza nella scelta del nostro partner? La psicologia ci dice che ogni volta si crea un intreccio di fattori speciale, chiamato “incastro di coppia” che renderà la storia di quei due partner unica rispetto alle altre.
Un elemento che spesso ci influenza è legato alle pressioni sociali. Chi non si è mai sentito porre in una certa fase della propria vita domande quali E allora la fidanzata/il fidanzato?? Quando ti sistemi?? Se poi siete già in coppia ce n’è anche per voi: quando andate a vivere insieme? quando vi sposate? quando mettete su famiglia? Possiamo fare spallucce, arrabbiarci, restarci male, in ogni caso a volte queste osservazioni ci colpiscono. D’altra parte ci è sempre stata tramandata l’idea che le persone “normali” prima o poi stabiliscono relazioni di copia stabili e possibilmente fanno dei figli, dunque mancare una tappa può farci sentire in difetto. Se cercate bene nel vostro albero genealogico potreste anche scoprire qualche parente “s-coppiato” da tutti considerato un po’ strano. Di certo oggi le cose sono cambiate rispetto al passato, ma stabilire rapporti affettivi è un bisogno umano e a volte le pressioni sociali rendono difficile ascoltare con serenità i propri desideri profondi e i propri tempi.
Il contesto socio-culturale e familiare può anche avere un peso nel determinare almeno un po’ le caratteristiche che andremo a cercare nel nostro partner: connotazioni fisiche, provenienza sociale ed etnica, caratteristiche di personalità e modi di fare potrebbero essere più o meno rispondenti ai modelli che ci sono stati tramandati e a ciò che gli altri considerano “appropriato”.
Anche la presenza di conflitti interiori e relazionali irrisolti, le esperienze passate e la particolare situazione in cui ci troviamo nel presente giocano un ruolo importante, ma ovviamente non è facile esserne consapevoli se non a posteriori.
E’ molto interessante provare a chiedere alle persone cosa le ha colpite del partner quando si sono conosciuti: gli aspetti, i gesti, i comportamenti che catturano la nostra attenzione dicono sempre qualcosa di noi e dei nostri bisogni più reconditi. Spesso accade di avere l’inconsapevole speranza che l’altro ci aiuti a gestire in modo diverso certe nostre difficoltà che non si sono dipanate all’interno di altri rapporti umani significativi. Ci sembra che l’altro abbia qualcosa di familiare, un’esperienza o un vissuto simile al nostro, per cui pensiamo che potrà capirci e accoglierci, ma anche qualcosa di diverso, una caratteristica o un modo di fare diverso che dunque potrebbe aiutarci e compensarci.
E’ assolutamente normale durante le prime fasi vivere in una sorta di bolla di amore incondizionato che ci fa sentire appagati e completi, ma con il tempo dobbiamo imparare a conoscere l’altro come persona reale e non è affatto detto che tutto ci piaccia! Vorremmo che l’altro fosse un po’ più simile a come vorremmo noi e curiosamente a volte è proprio ciò che ci aveva tanto attirato all’inizio a farci innervosire: un partner premuroso può diventare soffocante, uno dolce e indifeso può sembrarci ora una lagna, uno forte può apparirci d’un tratto menefreghista. Probabilmente non è però il partner ad essere cambiato: siamo noi a leggere i suoi comportamenti in modo diverso e ora possiamo osservare tutte le sfaccettature della sua personalità.
D’altra parte stare in coppia significa proprio imparare a conoscersi come persone reali, con i propri pregi e difetti, con le proprie capacità di esplorare il mondo, crescere e cambiare. E’ uno scegliersi e ri-scegliersi continuo finchè lo si desidera.
Possiamo allora provare il piacere di essere persone complete e autosufficienti per poi condividere con l’altro il nostro mondo, creandone uno comune e godendo della sensazione di essere una squadra. E’ questo continuo movimento di avvicinamento e allontanamento ad arricchire il rapporto.
Insomma, più che due metà della mela potete essere due ciliegie unite per il picciolo!
Autostima, questa sconosciuta!
La parola autostima è oggi molto in voga. Se un tempo si parlava forse troppo poco di questo tema, oggi è invece sulla bocca di tutti e molte persone pensano che gran parte delle difficoltà che incontrano nella vita sia legata proprio alla mancanza di autostima.
Certamente un buon livello di autostima ci aiuta a vivere meglio, tuttavia dobbiamo ricordare che non si tratta di una panacea contro ogni male: non tutto dipende dalla nostra autostima ed essa non ci rende immuni alle difficoltà della vita, ma piuttosto ci rende più attrezzati ad affrontarle.
Inoltre dobbiamo ricordare che il livello di autostima non è qualcosa di innato, né di stabile nel tempo: esso fluttua lungo l’arco della vita e nelle diverse situazioni, dunque è del tutto normale sentirsi di volta in volta più o meno adeguati, capaci, saggi o meritevoli.
La buona notizia è che non essendo qualcosa di predeterminato e fisso possiamo lavorarci: anche quando la vita ci ha posto di fronte a delle difficoltà non tutto è perduto, ma possiamo fare appello alle nostre risorse e provare a costruire qualcosa di buono per noi stessi.
Per fare questo è importante uscire da una concezione semplicistica del concetto di autostima, che in realtà è qualcosa di complesso, variegato e profondo. Avere autostima infatti non significa genericamente avere successo in qualche ambito nella vita e lavo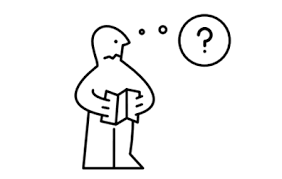 rare su se stessi non significa mettere in pratica qualche semplice esercizio.
rare su se stessi non significa mettere in pratica qualche semplice esercizio.
Se fatichiamo a tollerare di vivere momenti di infelicità e insicurezza, se ci lasciamo influenzare da una società che ci vorrebbe sempre vincenti e sorridenti, possiamo cadere nella trappola di cercare soluzioni rapide, concrete, che magari richiedono poco sforzo, con il rischio di restare delusi e di sentirci ancora più incapaci e infelici. Lavorare sulla propria autostima non è certo come montare un mobile seguendo un libretto di istruzioni!
Prima di buttarci sul fare dobbiamo capire dove vogliamo andare: se non capiamo cos’è l’autostima finiamo per pretendere di centrare l’obiettivo senza neppure sapere qual è il bersaglio e dunque dove mirare.
La parola autostima nella sua accezione più neutra indica il semplice fatto di attribuire un valore alla propria persona, positivo o negativo che sia. In questo senso potremmo dire che nessuno è del tutto privo di autostima: nessuno può vivere senza mai fare un pensiero o provare un sentimento riguardo a se stesso.
Comunemente invece si parla di avere autostima per indicare il fatto di avere un’opinione positiva di se stessi, cioè per indicare il tipo di valutazione che facciamo circa la nostra persona.
Una definizione che aiuta ad uscire un po’ dalla dicotomia positivo-negativo è quella data da Nathaniel Branden. L’autore ci parla del “sentirsi serenamente adeguati alla vita”, cioè sufficientemente attrezzati per provare ad affrontare le sue piccole e grandi sfide, e dunque possiamo riflettere su cosa ciò significhi per ognuno di noi.
Ancor prima però dobbiamo ritrovare una curiosità priva di giudizio verso noi stessi. Come possiamo contare su noi stessi e capire quali sono i nostri personali obiettivi se non sappiamo neppure chi siamo? come possiamo trovare una stabilità interiore se non partiamo dal nostro Sè?
Se provassimo ad esempio a descriverci con un disegno, con un oggetto simbolico o a completare di getto la frase “io sono…”, cosa verrebbe fuori?
Secondo Jung il Sé rappresenta l’unità e la totalità della personalità nella sua parte conscia e inconscia. E’ l’insieme di tutte le parti, consapevoli e inconsapevoli, che compongono ciò che noi siamo nel profondo.
Fin da piccoli, sperimentando il mondo, interagendo con le altre persone, iniziamo a percepire noi stessi, i nostri confini, la nostra interiorità. Osservando come ci muoviamo nell’ambiente, le reazioni interiori che proviamo e quelle che suscitiamo negli altri, ci facciamo un’ide a di chi siamo. Tutte le nostre esperienze, belle o brutte che siano, contribuiscono a formarci come persone.
a di chi siamo. Tutte le nostre esperienze, belle o brutte che siano, contribuiscono a formarci come persone.
Il nostro Sé diventa come un grande puzzle in cui ogni pezzo è importante. Qualcuno sarà più visibile, qualcuno più nascosto o più difficile da accettare, ma tutti fanno parte di noi.
Ritrovare la curiosità verso il proprio Sé, verso ciò che ci caratterizza come persone, senza giudizio, è dunque il primo passo per capire come funzioniamo e di cosa abbiamo bisogno e di conseguenza per lavorare sulla nostra autostima.
…noi abbiamo solo il nostro Sé con cui vivere e affrontare il mondo. Se non riusciamo a essere noi stessi certamente non possiamo appropriarci di un altro Sé, per quanto possiamo desiderarlo. Ogni Sé è diverso da tutti gli altri, è unico e la salute mentale dipende dall’accettazione di questa unicità…
(Rollo May)
Ma se invece di sopravvivere al Natale decidessimo come vivercelo?
E anche quest’anno è arrivato Natale con il suo carico di luci, pacchetti, cibo, canzoncine e… articoli sulla depressione e su come sopravvivere allo stress!
articoli sulla depressione e su come sopravvivere allo stress!
Basta guardarsi in giro e fare un rapido sondaggio tra le nostre conoscenze: il Natale è una festa tanto amata quanto odiata, in grado di far emergere i sentimenti migliori ma anche i peggiori. Probabilmente questo accade perché il Natale ci costringe a fare i conti con i nodi irrisolti della nostra vita e delle nostre relazioni e con una serie di pressioni sociali e familiari.
Il piacere di stare in famiglia o anche da soli a fare qualcosa di rilassante, il piacere di donare qualcosa e di riceverlo, il piacere di passare un momento in cui si abbandonano le tensioni si traduce a volte in una specie di imperativo categorico dove proprio la dimensione del piacere si perde: non importa cosa sia accaduto fino al giorno prima, a Natale bisogna stare tutti insieme, bisogna farsi i regali, bisogna sorridere ed essere gentili. A colpi di “si deve” si rischia di indossare una maschera e di passare le feste in apnea, contando le ore che ci separano dalla libertà e sperando che non ci siano spiacevoli incidenti diplomatici. A volte poi crediamo noi per primi che ogni tensione, ogni maleducazione, ogni distanza debba magicamente sparire in virtù dello spirito natalizio, restandoci malissimo se questo non succede. Per questo può anche capitare di decidere di fare altro a Natale, stando lontani il più possibile da certe situazioni. Ma anche questa spesso più che una scelta serena diventa una reazione rabbiosa, pur sempre un “si deve” anche se auto-imposto.
L’idea di dover stare tutti insieme, anzi più precisamente tutti insieme in armonia, rischia di provocare nervosismi o tristezze: la vicinanza alle cose e alle persone importanti (nel bene e nel male) se non si traduce in giusta distanza rischia di provocare reazioni emotive molto intense. Ecco allora che iniziano a scoperchiarsi antichi vasi di Pandora fatti di tensioni, risentimenti, pretese e intrusioni varie nelle vite altrui.
A Natale cose apparentemente banali come la scelta del luogo in cui festeggiare, del menu, del regalo, di come disporre la tavola possono diventare fonte di stress e terreno di scontro perché finiscono per assumere potenti significati simbolici di cui non sempre ci rendiamo conto. A Natale persino una fetta di pandoro smette di essere solo una fetta di pandoro e può diventare uno stress, una misura della nostra bravura e ospitalità, un messaggio subliminale, che ci sia da parte nostra un’intenzione in tal senso o no: il tipo di pandoro scelto, il modo in cui l’abbiamo tagliato, le dimensioni della fetta, il modo di servirlo e l’ordine con cui lo porgiamo ai presenti possono acquisire i più svariati significati.
Il Natale con il suo stare insieme moltiplica il peso di chi manca, dei legami persi, della solitudine, di ciò che non si ha, di ciò che c’era e non c’è più. Si può perdere la voglia di festeggiare perché si è soli, perché manca una persona cara, perché prevale la stanchezza. Ci si può sentire in difetto perché manca qualcosa che gli altri hanno o che in teoria sarebbe considerato normale avere, che si tratti di un partner, dei figli o del lavoro. Qualcuno potrebbe sottolineare ancora di più la situazione con commenti o domande inopportune, che fanno male. Si può anche passare il tempo a ricordare come era bello il Natale in passato, mentre adesso tante cose si sono perdute.
Avvicinarsi al Natale senza un equilibrio interiore significa rischiare di dare tanto spazio ai sentimenti negativi da perdere in gran parte o completamente la dimensione del piacere e a trarne un danno siamo solo noi. Che gli aspetti spiacevoli siano oggettivi o che siamo noi a dare alle cose un’interpretazione negativa, in ogni caso rischiamo di rovinarci la giornata, di lasciarla passare in sordina privandoci di qualcosa, di causare scontri o di “abboccare” alle provocazioni altrui. Quasi assicurato il risultato: ancora più negatività, stomaco attorcigliato, forse anche rimpianto per quella che invece poteva essere una festa più serena.
Non che si debba per forza trovare qualcosa di bello nel Natale, ma siamo sicuri di volerci limitare a subirlo e a sopravvivere ad esso invece che a viverlo? Il Natale è un classico momento di crisi in cui la distruzione si accompagna alla potenzialità creativa. . Lo spirito natalizio è quella stabilità interiore che vi permette di scegliere dove, con chi e soprattutto come trascorrere questo periodo. Cercate la giusta distanza, dopotutto siete voi a decidere quanto peso dare a cose e persone e a scegliere come comportarvi e reagire nelle diverse circostanze! Non vi aspettate che qualcuno vi infonda magicamente dall’alto lo spirito natalizio, cercatelo dentro di voi e portatelo fuori da voi stessi: riscoprite il piacere delle piccole cose e abbiatene cura, proponete qualcosa di carino da fare insieme o qualche dettaglio o regalo divertente, riscoprite qualche vecchia tradizione e createne di nuove e se siete soli non rinunciate a prendervi cura di voi stessi e a fare qualcosa che vi piace, fosse anche stare su divano a leggere un libro contornati di lucine colorate. Buon Natale!
La percezione degli altri: l’importanza delle prime impressioni
 “L’abito non fa il monaco” dice il proverbio, eppure tutti noi quando incontriamo un’altra persona o quando semplicemente la osserviamo costruiamo una prima impressione su di essa. Anche se razionalmente sappiamo che le prime impressioni sono superficiali e che dovremmo andare oltre, spesso non abbiamo la possibilità di farlo e anche quando sarebbe possibile non lo facciamo. Dobbiamo inoltre essere consapevoli del fatto che una volta costruita un’opinione sugli altri non è affatto facile modificarla.
“L’abito non fa il monaco” dice il proverbio, eppure tutti noi quando incontriamo un’altra persona o quando semplicemente la osserviamo costruiamo una prima impressione su di essa. Anche se razionalmente sappiamo che le prime impressioni sono superficiali e che dovremmo andare oltre, spesso non abbiamo la possibilità di farlo e anche quando sarebbe possibile non lo facciamo. Dobbiamo inoltre essere consapevoli del fatto che una volta costruita un’opinione sugli altri non è affatto facile modificarla.
Siamo naturalmente portati a pensare che l’aspetto delle persone e quello che le persone dicono e fanno riflettano caratteristiche della loro personalità, il loro stile di vita o le loro preferenze personali. Questo succede perché crescendo accumuliamo nella nostra memoria moltissime conoscenze sulle caratteristiche delle persone, sulle situazioni, sui gruppi sociali e queste informazioni ci influenzano e ci forniscono una sorta di guida rapida per orientarci nella vita quotidiana.
Le prime impressioni si basano principalmente su tre elementi.
- L’aspetto fisico è il primo e spesso il solo indizio a nostra disposizione e possiamo attribuirvi molti significati. Ad esempio gli occhiali possono farci pensare a una persona intellettuale, giacca e cravatta a una persona distinta, un viso dai tratti infantili a una persona gentile e onesta. Anche se razionalmente sappiamo che queste associazioni non sono sempre veritiere, quando incontriamo uno sconosciuto automaticamente facciamo affidamento su questi indizi per orientarci. Anche se può sembrarci un atteggiamento molto superficiale, si tratta di un meccanismo che spesso si rivela utile: se ad esempio vediamo una persona dall’aria minacciosa e con un’arma in mano siamo subito in grado di capire che dobbiamo scappare. Che ci piaccia o no sappiamo che il nostro aspetto fisico è la prima cosa che appare e infatti di solito nelle occasioni in cui vogliamo fare buona impressione tendiamo a curarlo maggiormente.
- Il comportamento non verbale, dunque elemenqui quali l’espressione del viso, lo sguardo, il tono di voce, la postura, possono trasmettere molte informazioni. Possiamo preferire le persone che mentre parliamo si pongono di fronte a noi e annuiscono perché interpretiamo ciò come interesse verso di noi. Chi ci guarda spesso negli occhi può sembrare cordiale e onesto, mentre chi evita lo sguardo può apparire scortese, sfuggente o timido. Se una persona sconosciuta ci guarda in modo insistente o ci si avvicina troppo a noi possiamo pensare che sia invadente o ostile. Spesso siamo poco consapevoli dell’effetto che il nostro comportamento non verbale può avere sugli altri.
- I comportamenti, dunque ciò che una persona fa, vengono solitamente interpretati come se riflettessero aspetti della sua personalità. Questo accade soprattutto con alcuni particolari comportamenti: facilmente penseremo che chi fa volontariato sia altruista, che chi ruba sia disonesto e che chi picchia sia un violento.
Ci sono indizi che più di altri catturano la nostra attenzione, perchè sono nuovi, appariscenti, diversi nel contesto in cui ci troviamo. Un uomo vestito in modo elegante che spinge un passeggino probabilmente attirerà la nostra attenzione per il suo abito se ci troviamo a una festa per bambini. Potremmo pensare che sia una persona formale e sostenuta. Se invece ci troviamo a una cena di lavoro la nostra attenzione potrebbe essere attirata dal passeggino e potremmo pensare che quell’uomo sia un padre molto affezionato al suo bambino o che non abbia trovato una baby sitter disponibile a tenere il figlio per quella sera.
In realtà gli indizi che usiamo per costruire prime impressioni sugli altri non hanno significato di per sé, non indicano direttamente caratteristiche di personalità: siamo noi che in modo rapido e spontaneo li interpretiamo in base alle conoscenze che abbiamo accumulato.
I pensieri che abbiamo in mente in quel momento, le aspettative, l’umore, le motivazioni sono tutti elementi che possono portarci a interpretare uno stesso indizio in un modo piuttosto che in altro. Inoltre di solito più usiamo un certo concetto per interpretare gli indizi, più quel concetto diventerà automatico e più un pensiero è recente più tenderà ad influenzarci. Ad esempio è più probabile interpretare come ostilità i comportamenti altrui se siamo arrabbiati, se siamo in competizione con quella persona, se nella vita abbiamo sperimentato molte situazioni negative, di pericolo e minaccia, o subito dopo aver visto un film particolarmente aggressivo.
Un altro elemento che ci aiuta a interpretare gli indizi è il contesto in cui ci troviamo, perché ci fornisce altre informazioni utili a interpretare il comportamento e l’aspetto altrui.

Dunque partendo dall’aspetto, dal comportamento e dal comportamento non verbale degli altri selezioniamo gli indizi più salienti e attiviamo delle immagini mentali che ci permettono di fare delle interpretazioni in termini di tratti della personalità.
Si tratta di un processo superficiale che può comportare degli errori. Razionalmente sappiamo che un comportamento può avere molte ragioni diverse e per questo a volte ci sforziamo di andare oltre le prime impressioni, provando a trovare una causa al comportamento altrui.
Ci sono comportamenti che ci sembrano legati a determinate cause in modo ovvio e automatico, soprattutto se quella situazione ci è familiare e dunque riconosciamo i comportamenti normali in quel contesto. Ad esempio se vediamo una persona piangere a un funerale potremo facilmente pensare che pianga perchè in quel momento è triste. E’ più difficile dare una spiegazione a un comportamento imprevisto rispetto a ciò che consideriamo normale in quella situazione.
In questo processo di ricerca di cause e spiegazioni siamo influenzati da alcuni elementi, come la cultura di appartenenza, il fatto che una certa spiegazione ci venga in mente più velocemente o in modo più lampante, la situazione contingente in cui quel comportamento si è verificato.
Se in ufficio vediamo un collega che si mangia le unghie mentre aspetta di parlare con il capo possiamo pensare che sia una persona nervosa. Facendo uno sforzo in più, soffermandoci su quella particolare situazione, potremmo renderci conto che il nostro collega non è una persona nervosa in generale, ma è nervoso in quello specifico momento.

Il problema è che ragionare per correggere le nostre prime impressioni richiede tempo ed energia, dunque spesso non lo facciamo o lo facciamo in modo superficiale.
Se vogliamo farci un’idea più accurata dell’altro inoltre dobbiamo mettere insieme tutti i diversi indizi raccolti in un’immagine sufficientemente coerente. Una persona che lavora in banca, si vanta di guidare automobili costose e nel tempo libero fa teatro e volontariato può sembrarci al contempo una seria e impostata, vanitosa e materialista, creativa e altruista. Come possiamo mettere insieme in modo coerente queste informazioni?
Innanzitutto costruiamo vere e proprie teorie implicite di personalità: in base alle esperienze di vita e alla cultura di appartenenza tendiamo a pensare che certe caratteristiche vadano insieme. Se fa volontariato sarà generoso e anche socievole, se ha rubato è disonesto e sarà anche egoista, se fa sport estremi sarà coraggioso e quindi anche sicuro di sé.
In secondo luogo raggruppiamo le caratteristiche simili, quindi una persona che fa volontariato, che sostiene campagne pubblicitarie di tipo sociale e si occupa di politica a livello locale probabilmente ci apparirà come una persona socialmente attiva.
Infine cerchiamo di dare un senso ai comportamenti legandoli a particolari caratteristiche di personalità: una persona che occupa un posto di grande responsabilità in un’azienda e che è anche irascibile forse sarà molto competitiva e forse questo può spiegarci sia il suo successo lavorativo sia i suoi scoppi d’ira.
Nella ricerca di una spiegazione plausibile le nostre speranze e i nostri desideri ci influenzano: di solito cerchiamo prove che ci permettano di confermare la conclusione a noi più gradita. Se una persona ci piace probabilmente interpreteremo i suoi comportamenti in modo più positivo, trovando una spiegazione che non ci costringa a modificare negativamente la nostra opinione.
E’ invece nel momento in cui siamo fortemente motivati a costruire impressioni davvero accurate che facciamo uno sforzo in tal senso, ad esempio quando dobbiamo affidare all’altro un compito importante o lavorarci insieme o in tutte quelle situazioni in cui ci interessa avvicinarci all’immagine reale dell’altro qualunque essa sia.
Una volta che ci siamo fatti un’opinione sull’altro la useremo per orientare i nostri comportamenti, le nostre relazioni, i nostri giudizi: se cerchiamo un collaboratore affidabile non sceglieremo un candidato che non ci sembra tale perché magari arriva in ritardo; se vogliamo un coinquilino con cui divertirci preferiremo probabilmente quello a cui piace organizzare delle feste; se per noi in amicizia la sincerità è importante tenderemo a non approfondire i rapporti con chi non si comporta in modo trasparente e così via.
Ciò significa anche che i comportamenti che gli altri hanno nei nostri confronti potrebbero essere non tanto legati a loro caratteristiche di personalità, ma all’immagine che spesso inconsapevolmente diamo di noi stessi e al modo in cui i nostri comportamenti sono interpretati. Per questo motivo in terapia uno degli aspetti su cui spesso si lavora è il diventare più consapevoli degli effetti che i nostri atteggiamenti possono avere sugli altri.
Una volta che ci siamo costruiti un’impressione dell’altro non è facile modificarla, neanche quando scopriamo che l’impressione iniziale non era accurata o era falsa. Mentre conosciamo l’altra persona e raccogliamo altre informazioni infatti tendiamo a valorizzare di più gli indizi coerenti con l’idea che già abbiamo, interpretiamo i nuovi indizi in modo da adattarli all’immagine che già ci siamo costruiti e inoltre tendiamo a trattare le altre persone in modo coerente con le nostre aspettative. In questo modo spesso senza rendercene conto noi stessi suscitiamo negli altri proprio i comportamenti che ci aspettiamo da loro e così non siamo costretti a cambiare opinione sull’altro, ma anzi continuiamo a rinforzare l’idea che ci eravamo fatti.
Questo significa che soprattutto quando ci troviamo in difficoltà con una persona dobbiamo chiederci tra le altre cose se non siamo proprio noi a interpretare in modo negativo tutti i suoi comportamenti o provocare inconsciamente determinati comportamenti da parte sua.
Ad esempio, possiamo provare istintiva antipatia per un’altra persona, perché i suoi comportamenti e atteggiamenti ci appaiono sgradevoli e magari ci sembra che nel tempo quella persona si sia comportata in modo negativo. In base all’opinione che ci siamo fatti possiamo finire per dare molto peso a tutto ciò che ci conferma questa idea, ignorando i momenti in cui l’altro si è comportato bene o interpretando tutti i suoi comportamenti in modo negativo, ad esempio pensando che abbia agito in modo falso, magari per ottenere qualcosa. Possiamo cercare attivamente prove della sua cattiveria facendoci raccontare altri episodi in cui non si è comportato bene e possiamo addirittura fornirgli nuove occasioni per darci prova della sua negatività, ad esempio provocandolo apertamente o comportandoci senza rendercene conto in modo tale da farlo arrabbiare o da suscitare le sue critiche. Ma se un giorno quella persona facesse qualcosa di positivo, di così positivo da entrare palesemente in contrasto con l’opinione che ci eravamo costruiti? Potremmo ancora negare l’evidenza?

Ebbene sembra proprio di sì! Quando siamo motivati a non cambiare la nostra opinione sull’altro la nostra mente si sforza di tenere insieme le informazioni incoerenti: cerchiamo una spiegazione e un senso a quel comportamento inaspettato e spesso ne troviamo la causa in situazioni particolari e circoscritte.
In realtà è quando ci troviamo di fronte a comportamenti inaspettati forti, estremi e non ambigui, per quali non troviamo nessuna spiegazione plausibile o quando siamo fortemente motivati a cambiare idea che abbiamo più probabilità di fare uno sforzo ulteriore, modificando l’immagine che abbiamo dell’altro.
Ne deriva quindi che se ci rendiamo conto di aver dato all’esterno un’immagine che non ci piace o che non è in linea con ciò che sentiamo di essere o con ciò che siamo diventati, allora dobbiamo innanzitutto imparare a riflettere sul nostro comportamento, renderci conto che gli altri si sono abituati a vederci in un certo modo e impegnarci ad agire diversamente, in modo chiaro e coerente.
Bibliografia
E.R. Smith, D.M. Mackie, Psicologia Sociale, Ed. Zanichelli, 2004
Insonnia, ansia e stress: se tra benzodiazepine e pensieri lieti ci si dimentica di ascoltarsi
Qualche giorno fa sul Corriere della Sera è stato pubblicato un articolo dal titolo “Milano non sa dormire. Contro stress e ansia in farmacia si vendono 100 sonniferi al minuto”

L’articolo riporta i dati di una ricerca condotta dalla società New Line ricerche di mercato, secondo la quale ogni giorno nella città di Milano vengono vendute 6100 confezioni di farmaci per dormire. Stiamo parlando di oltre 128 mila pillole o dosi di gocce acquistate in 24 ore. I sonniferi rappresenterebbero il 6% dei farmaci venduti ogni anno e a farne uso sarebbe l’11% della popolazione sopra i 18 anni. In realtà i dati sul numero di abitanti ci dicono che anche nelle altre città si fa un certo uso di farmaci per dormire: a Roma li utilizzerebbe il 12% della popolazione, a Torino il 13%, a Firenze il 14%, a Bologna il 15%.
Gli esperti intervistati affermano che stress e ansia sono la prima causa di insonnia e che i farmaci più utilizzati sono le benzodiazepine, cioè medicinali che andrebbero venduti solo dietro ricetta medica e che andrebbero utilizzati sotto controllo medico e per periodi di tempo limitati, poiché possono avere effetti collaterali e generare dipendenza.
Ora, l’esperienza in realtà ci dice che diverse persone usano questi farmaci per periodi di tempo molto prolungati, anche a vita, senza farsi monitorare da alcun professionista, ottenendoli talvolta anche senza ricetta medica, con il concreto rischio di sviluppare una dipendenza e senza risolvere il proprio problema. Quando il medico prescrive farmaci del genere solitamente le raccomandazioni sul loro uso o l’eventuale consiglio di intraprendere un percorso di supporto psicologico passano in secondo piano e non è affatto detto che vengano seguiti. Sebbene infatti in certi casi i farmaci siano utili e talvolta indispensabili, l’idea di poter mettere a tacere l’ansia e lo stress con una pillola o qualche goccia risponde proprio al tipo di società in cui siamo immersi: una società del fare, dove si va di fretta, dove i malesseri fisici e psichici vengono trattati come seccature o vergogne da eliminare perchè dobbiamo essere in forma e sorridenti e chi si ferma a guardarsi dentro e intorno rischia di perdersi nei propri baratri interiori o di sentire che tanto non c’è soluzione, provando ancora più infelicità e frustrazione.
Dunque preoccupa, ma non stupisce, che nell’articolo non si faccia il minimo accenno allo psicologo come figura che può essere di aiuto in situazioni simili e che invece si riporti l’opinione di un noto avvocato matrimonialista, il quale afferma: “Sono arrivato alla conclusione che per addormentarsi tranquillamente bisogna sempre pensare alle cose liete”.
Premesso che quando si parla di disturbi del sonno è sempre bene verificare che non vi siano alla base problematiche di tipo organico, certi “consigli” appaiono riduttivi e banalizzanti. E’ un po’ come confidare un periodo di difficoltà a un amico o a un familiare e sentirsi rispondere “non pensarci”, “passerà”, “sei solo stressato”, “ti lamenti sempre”, “sei troppo ansioso”, “non è nulla, sei esagerato”, “e cosa dovrei dire io allora?” e altre risposte di questo tenore che fanno ben intuire quanto certe difficoltà negli altri possano essere vissute con fastidio o appunto con ansia, tanto da essere liquidate in tal modo.
Ansia e stress sono qualcosa che noi tutti conosciamo, magari non siamo persone particolarmente soggette a questi vissuti, ma ci sarà capitato almeno una volta nella vita di provarli dentro di noi. Possiamo vivere momenti di stress tutto sommato circoscritti e temporanei, pensiamo ad esempio a un esame o a un impegno lavorativo particolare, ma anche eventi generalmente considerati gravosi come la perdita del lavoro, un trasferimento, un divorzio, una malattia, la perdita di una persona cara. Possiamo anche arrivare a vivere la maggior parte della nostra vita in ambienti stressogeni, pieni di pressioni, in cui non ci troviamo bene con gli altri, in cui ci viene chiesto troppo o non ci sentiamo valorizzati, in cui cerchiamo di conciliare tutto correndo qui e là come trottole impazzite, in cui vorremmo ma sentiamo di non potere. A volte l’ambiente stressogeno è dentro di noi, i conflitti interiori diventano tali da non farci godere niente del nostro quotidiano e non c’è esperienza rilassante che tenga. Concentrarsi sulle cose positive, così come imparare delle tecniche di rilassamento o avere alcuni accorgimenti prima di andare a dormire (ad esempio evitare attività troppo stimolanti per il cervello), può aiutarci a rilassarci nei momenti più critici, ma questo certamente non basta se non ci diamo anche il permesso di sentire l’ansia, di interrogarla, esplorarla, di capire come funziona.
Per gestire l’ansia dobbiamo imparare a conoscerla, altrimenti possiamo solo cercare di bloccarla, di estirparla come se fosse qualcosa di estraneo e disdicevole, ma l’ansia c’è per un motivo, dice qualcosa di noi e della nostra vita, ci parla, ci dice che qualcosa non torna, che dobbiamo prenderci cura di noi. Forse abbiamo paura di ascoltare, ma seppellirla sotto un mucchio di pensieri lieti o di pillole rischia di renderla più forte. I pensieri lieti, le esperienze positive, le piccole gioie non devono diventare il classico tappeto sotto cui nascondere la polvere, né corde a cui restare disperatamente aggrappati sperando che non si consumino – nè tantomeno limitarsi a ostentazioni di finto benessere – ma casomai i pioli di una scala che attentamente intrecciata ci aiuta a calarci nelle profondità di ciò che non va con meno paura, con l’obiettivo di fare chiarezza, accettare certe nostre fragilità e potenziare le nostre risorse, capendo cosa è in nostro potere cambiare e come per avere una qualità di vita migliore.



